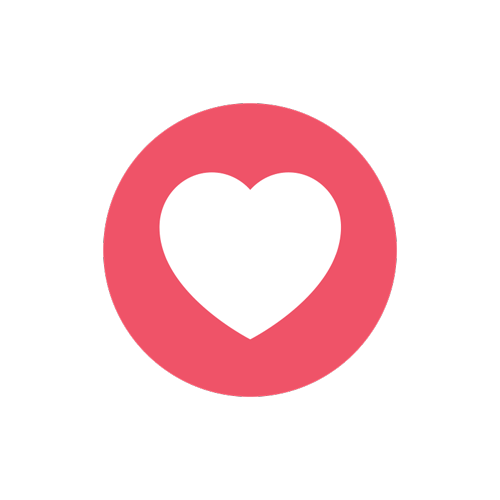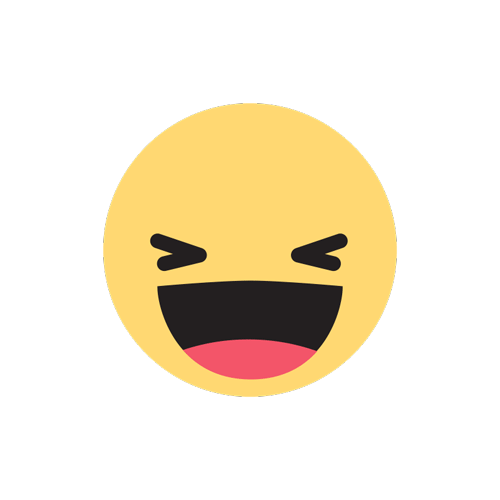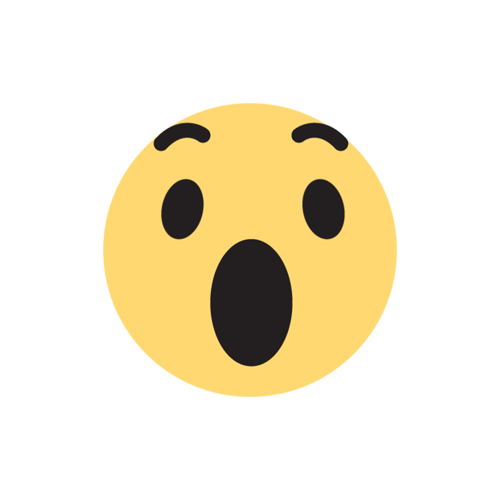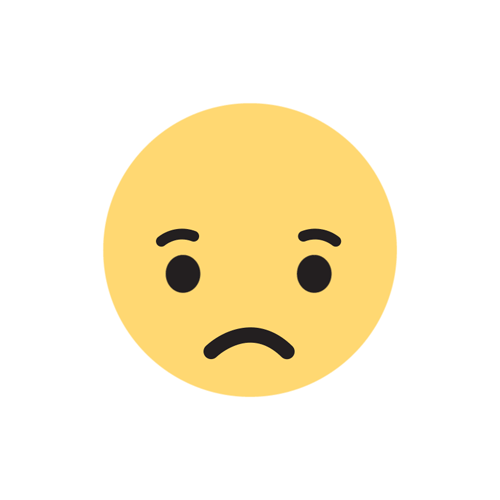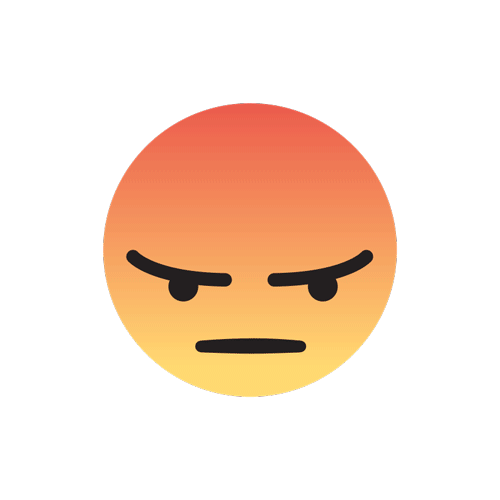Fino a qualche anno fa il nome di Francesco Messina era quasi del tutto assente nei manuali di Storia dell’Arte. Non ne parla il militante Argan, non il formalista Barilli e non l’eclettico Dorfles. Nessun cenno anche nel celebre Cerchiari-De Vecchi, che ha formato più di una generazione di studenti. E potremmo continuare con Poli, De Micheli, Calvesi, Vettese e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Messina, che pure è stato tra gli artisti più attivi del secolo scorso, è stato categoricamente ignorato dalla critica che lo ha sempre considerato troppo mainstream.
La sua voce è presente solo nella generalista Enciclopedia dell’Arte Garzanti, ovviamente alla lettera M, tra due colleghi scultori, in rigoroso ordine alfabetico: Franz Xavier Messerchmidt (consigliamo il capitolo che i Wittkower gli dedicarono in Nati sotto Saturno) e Ivan Mestrovic. «La solidità del mestiere – si legge – gli ha permesso di adeguarsi ai modelli prescelti, dal vigore muscolare dei Pugilatori, alla grazia donatelliana, tutta scatti e spigolosità, del Nuotatore sulla spiaggia; dai ritratti alle figure di donna, dapprima rese in una opulenza che massifica la forma alla Maillol, poi con modernità acerba e provocante. Fra le ultime opere ricordiamo i vitalistici cavalli».

Già, i cavalli. Quello morente che tutti hanno bene impresso è divenuto il simbolo della Rai, davanti agli studi di piazza Mazzini a Roma dal 1966. Da allora, Francesco Messina è stato, con un giudizio piuttosto arbitrario e limitativo, l’artista dei cavalli. Tuttavia, come spesso accade, chi ha voglia e curiosità di girare la prima pagina del libro per continuare a leggere la storia scoprirà che Messina, nato a Linguaglossa il 15 dicembre del 1900 e morto a Milano il 13 settembre del 1995, cioè nell’arco temporale da quando il nuovo secolo stava emettendo i suoi primi vagiti a quando stava per esalare gli ultimi respiri, merita qualcosa in più di una semplice e sommaria catalogazione.
La critica lo sta rivalutando e questo è un dato di fatto. Prova ne sia la mostra vercellese Prodigi di Bellezza che verrà inaugurata sabato 18 e che è dislocata in ben tre sedi: il Palazzo Arcivescovile che ospiterà le opere a soggetto religioso; Arca che esporrà il corpus principale con i ritratti, le ballerine, i giovinetti, i pugilatori, i nudi, i cavalli; l’ex chiesa di San Vittore con un’installazione creata ad hoc. In tutto 120 opere, il cui numero, 120 appunto, è uguale agli anni passati dalla nascita di Messina.

Di solito si dice che è stato tra i più grandi scultori del Novecento e questo è vero, ma il suo nome viene spesso dimenticato negli elenchi. Si citano Giacomo Manzù, Arturo Martini, Adolfo Wildt, Marino Marini, Giuliano Vangi e solo alla fine, se capita, Francesco Messina che – vale la pena ricordare – è stato per anni direttore dell’Accademia di Brera, Accademico d’Italia, vincitore dei più importanti premi artistici, protagonista più volte alla Biennale d’Arte di Venezia, senza contare, ma questo è sottinteso essendo il motore da cui tutto è generato, la paternità delle sue innumerevoli opere, esposte nei musei, nelle collezioni private e nelle piazze delle città.

Ad aiutare una mente, già fertile di suo, le amicizie e le frequentazioni con poeti, scrittori e intellettuali. Che per Messina spesero parole di elogio, come Giorgio De Chirico, il quale nel 1938 scrisse come le sue sculture «ovunque si trovino, fanno piacere a guardare, vivono con gli uomini e li consolano con la loro presenza». O Salvatore Quasimodo, siciliano come lui (e protagonista di uno dei ritratti in mostra), che lo definì spirito apollineo e meditativo.
Perché di dionisiaco in Messina effettivamente c’è poco o nulla. Le sue sculture sono perfette, troppo verrebbe da dire, ed è per questo motivo, per il suo essere ostinatamente classico, che gli storici dell’arte sopra menzionati hanno preferito tacere. Del resto il Novecento è stato il secolo delle avanguardie, dei movimenti di protesta, dell’emancipazione dell’arte americana, del postmoderno, della globalizzazione, di un dinamismo che mai si era visto prima. Un tumulto incessante di idee di cui Francesco Messina era consapevole, perché ci viveva dentro, ma che forse non lo interessava più di tanto.

Meglio allora meditare sull’arte del passato, sulle tecniche di lavorazione, sui materiali, da lui sempre rispettati e mai traditi o maltrattati. Degli esercizi di stile che erano volutamente fuori dalla storia, quantomeno quella contemporanea. Alla presentazione in anteprima, ha detto bene Sandro Parmiggiani, uno dei curatori della mostra assieme a Marta Concina e a Daniele De Luca, invitando gli ospiti a osservare un nudo in marmo bianco: «partendo da questa scultura è possibile intraprendere un percorso a ritroso nella Storia dell’Arte: vediamo l’Olympia di Manet, poi ancora indietro la Paolina Borghese di Canova, fino alla Venere di Tiziano». In scultura Messina si pone sulla linea che in pittura avevano tracciato Poussin e Ingres, emuli dichiarati del classico, che quel classico volevano recuperare.
È questo il linguaggio che esprimono le opere della mostra Prodigi di Bellezza: i ritratti di Lucio Fontana, Salvatore Quasimodo, Riccardo Bacchelli con il monocolo, Alfonso Gatto, Arturo Tosi, Eugenio D’Ors, Ranieri III, Pio XII, Carla Fracci, Luciana Savignano, Aida Accolla; le danzatrici, i nudi, le formelle con scene religiose, il bozzetto per il monumento a Cristoforo Colombo e infine, nell’ultimo spazio, a chiudere il cerchio, i cavalli con la gigantografia di quello della Rai.
E chissà che standoci davanti e rimirandole da più angolazioni non tornino alla mente le parole di un altro amico di Messina, Eugenio Montale: «è un’armoniosa e ferace giovinezza la sua, che si esprime in opere di ritmo e leggiadria. È in lui una mirabile capacità di trasformarsi nelle versioni e nelle forme più disparate, un dono profondo e primordiale. Anche in lui l’uomo non è al di sotto dell’artista. Ci sono delle cose molto belle nella sua vita, dalle quali non toglierò il velo a nessun patto». Non ce n’è bisogno, ci sentiamo di aggiungere, perché per fortuna nostra il velo già lo ha tolto Messina regalandoci le sue sculture. A noi il compito di accarezzarle con gli occhi.
Massimiliano Muraro