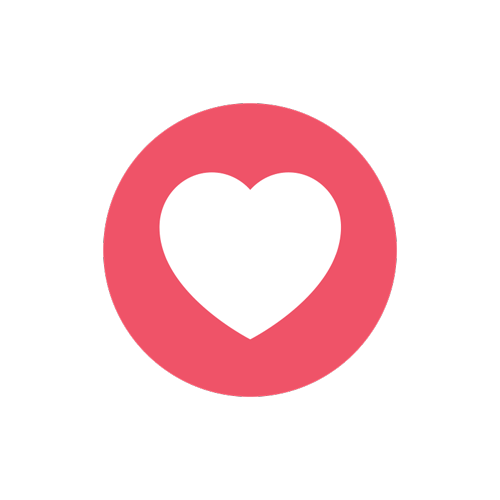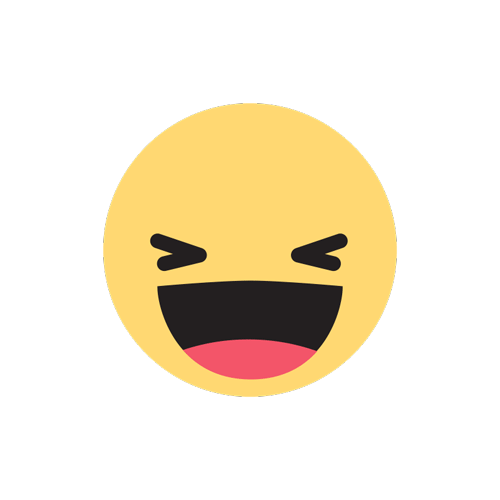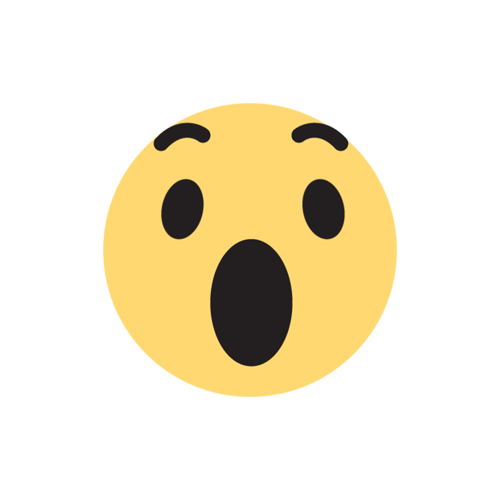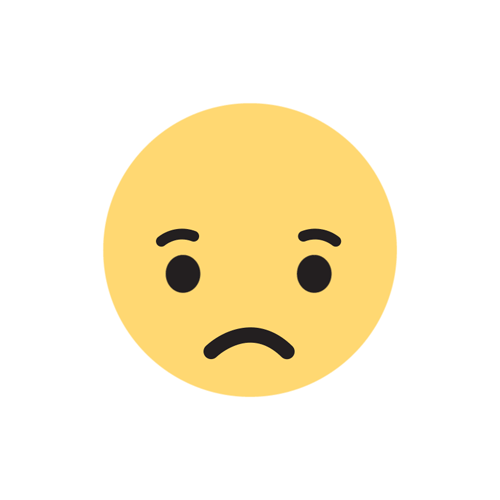C’è da scommettere che ad Angelo Gilardino sarebbe piaciuto l’allestimento della mostra a lui dedicata, inaugurata in Arca nell’ex chiesa di San Marco venerdì 17 novembre e aperta fino all’8 gennaio 2024. Avrebbe approvato anche il titolo, Il legno che canta, lo stesso che lui aveva pensato per il libro in cui prendeva in esame i più importanti liutai italiani del XX secolo e che definisce l’intera rassegna non soltanto di mostre, ma anche di concerti, seminari e conferenze, che celebrerà per intero l’opera del Maestro.
Per l’occasione il contenitore progettato nel 2007 dall’architetto Ferdinando Fagnola per ospitare i capolavori della Fondazione Guggenheim si è liberato di inutili orpelli e si presenta qui nella sua veste più elementare: un parallelepipedo spoglio dove alle pareti sono appesi i quadri provenienti dalla collezione del mercante bresciano Italo Segalini e dove sui piedistalli si possono ammirare le chitarre del liutaio modenese Lorenzo Frignani.
In sostanza è come entrare nella sala di un museo che espone le due passioni di Angelo Gilardino: l’arte e la musica. Per quel che riguarda la prima, ci troviamo di fronte a un’esaustiva sintesi dell’Ottocento italiano, rappresentato dai suoi pittori più illustri: Giacomo Grosso, Massimo Taparelli D’Azeglio, Gerolamo Induno, Angelo Inganni.
C’è stato un tempo, in verità neppure troppo lontano, in cui gli storici dell’arte storcevano il naso quando gli si chiedeva un giudizio sulla produzione italiana nel XIX secolo. Non bisogna per questo rimproverarli. Sedotti dal fascino ammaliante delle avanguardie, che avevano tagliato i ponti anche violentemente con il passato (si pensi al Futurismo tanto per non uscire dai nostri confini), era logico che i critici, soprattutto quelli militanti, non avessero remore a condannare l’arte italiana di quel periodo, catalogata senza possibilità d’appello come borghese. L’unica eccezione che tolleravano era per quella francese che gli aveva servito su un piatto d’argento l’Impressionismo.
Secondo Giulio Carlo Argan i problemi vanno ricercati nella condizione storica vissuta allora dall’Italia, in cerca di una sua indipendenza nazionale. Se nel resto dell’Europa si irradiavano gli influssi del Romanticismo, qui i pensieri erano altri, primo tra tutti come liberarsi dalla dominazione straniera e dalle monarchie reazionarie. In poche parole come raggiungere l’unità nazionale.
L’arte italiana dell’Ottocento è un coacervo di esperienze molto mescolate fra di loro e poco omogenee. Troviamo chi, come Hayez, si interessa alla storia riprendendo il disegno di Ingres; chi, come la Scapigliatura, guarda con intelligenza al Romanticismo; chi, come Boldini, ha Parigi come punto di riferimento; chi, come i Macchiaioli, mira a un realismo quasi fotografico; chi come Diego Martelli prima e Silvestro Lega poi, capisce la portata storica dell’Impressionismo.
Questi pochi esempi coevi sì, ma allo stesso tempo distanti come impianto ideologico, non sono che la figurazione di ciò che era in quel momento l’Italia: un insieme di frammenti che di lì a poco si sarebbero composti per formarsi in Nazione.
Crediamo che i quadri esposti in Arca siano una parte tangibile di questo processo di lenta omologazione linguistica, ché a ben vedere di una lingua era alla ricerca l’Italia che germinava l’unificazione, fosse sociale, politica, economica e artistica.
Sono 22 in tutto i quadri in Arca, che spaziano dalla ritrattistica, al soggetto storico, allegorico, vedutistico, di genere e di costume. C’è la dama con velo di Francesco Vinea che ammicca alle tonalità tenui di Boldini, qui evidenti nelle pennellate chiare e vaporose del tessuto che cinge il capo della donna; la signora con rosa e con viole di Emilio Rizzi, debitrice di Renoir; la Primavera di Federico Andreotti che si bea della sua abilità tecnica, visibile anche ne La visita alla balia, vero e proprio tableau vivant.
Ancora Il corteggiamento di Vincenzo Cabianca e Faust che tenta Margherita di Antenore Soldi, lineari nella loro semplicità e purezza nazarena, con un disegno che possiamo far risalire a Raffaello e che passa da Poussin per approdare a Ingres. Il Faust che tenta Margherita è inoltre un esempio tipico di trasportare in pittura il romanzo, in particolare quello storico, come si evince in Antonio Varani con il suo Padre Cristoforo in casa di Agnese.
La storia, quella vera, ce la propone Giovanni Giani che raffigura L’incontro con il re con uno scorcio prospettico che non può non ricordare quello della Vedetta del macchiaiolo Fattori. Di tutt’altro tenore Gli innamorati e Ruscello nel bosco, che si immergono in una natura piuttosto confidenziale e rassicurante.
Sempre la storia, ma più antica, è protagonista dell’opera di Massimo Taparelli D’Azeglio (di certo il nome più conosciuto tra quelli in mostra) Muzio Attendolo Sforza che lancia l’accetta sull’albero, soggetto che l’autore ha trattato più volte nel corso della sua vita, fatto significativo per il suo valore didascalico: il protagonista, capitano di ventura, proveniente dalla famiglia degli Attendoli fu il padre di Francesco, capostipite della celebre dinastia milanese degli Sforza. Un atto di fondazione dunque, come quello che cercava il patriota Massimo D’Azeglio che espresse il suo credo non soltanto in pittura, ma anche attraverso la scrittura di romanzi come l’Ettore Fieramosca o la disfida di Barletta (1833).
Dicevamo della storia, che non è soltanto quella che si studia nei libri, ma pure quella della quotidianità. Ed è nell’Ottocento che assistiamo alla fortuna di quadri che rappresentano scene di tutti i giorni, sovente commissionati dalla borghesia. Ecco quindi le Gioie materne di Luigi Busi in cui una madre di bianco vestita, nell’intimità della sua camera da letto, solleva al cielo il suo piccolo, mentre dietro il figlio adolescente lo fa sorridere con un ventaglio orientaleggiante.
Il Matrimonio in cascina di Achille Glisenti invece risulta fin quasi artefatto nella sua composizione e nella sua opulenza, a tratti troppo smaccata per il contesto. La caccia alla volpe di Carlo Pitarra fa da contraltare ai Pescatori in laguna del veneto Guglielmo Ciardi: passatempo per trascorrere le ore oziose di una classe agiata l’uno, lavoro necessario per la sopravvivenza l’altro, senza però raggiungere la denuncia sociale di Courbet o di Daumier.
Più di questo tenore è L’aratura di Luigi Steffani che richiama L’Angelus di Millet, da cui riprende l’etica e la religiosità del lavoro nei campi, qui mediato dalla poetica della Scapigliatura. Vi è poi l’allegoria di Ricchezza e povertà di Giuseppe Puricelli con quel che rimane di un’ambientazione romantica che non è più magniloquente come quella delle origini. La nevicata a Milano di Angelo Inganni altro non è che un’istantanea di vita meneghina in pieno inverno, uno sprazzo di vedutismo che è molto più palese nella Torre di Belem di Enrico Gamba.
Nei Suonatori ambulanti di Gerolamo Induno (fratello di Domenico) mi par di ravvisare delle cromie tipiche di Silvestro Lega, sebbene il disegno tradisca delle simpatie per quello di Hayez. Un discepolo di quest’ultimo fu Enrico Crespi che in Arca si può osservare In chiesa, quadro su due piani su cui scorrono le età della vita di una donna: sui banchi in basso le tre bambine pensano a tutto fuorché alla celebrazione, in alto tre giovani hanno tre atteggiamenti diversi: due fanno sogni e progetti sul futuro, una sola legge compita il messale. Infine sulla sinistra la vecchia che prega è l’unica a partecipare attivamente alla Messa.
Infine la tela che domina lo spazio espositivo, per ragioni oggettive collocata nella parete di fondo, data la sua mole (253×395) è la Sacra Famiglia di Giacomo Grosso, esposta alla prima edizione della Quadriennale di Torino nel 1902 e nel Salon di Parigi nel 1903, anno in cui ricevette la medaglia d’oro. È uno dei rari soggetti religiosi dell’artista il quale negli anni precedenti aveva suscitato enormi scandali con Il supremo convegno e soprattutto per la Nuda. Non qui dove i protagonisti sono collocati in quella che pare una bottega cittadina con tanto di vetrina e tenda per rispettare la riservatezza. Al centro un Gesù adolescente, a piedi nudi tra i trucioli di legno, predica a una piccola folla accorsa sull’uscio, mentre Giuseppe al tavolo di lavoro e Maria più discosta prestano attenzione.
Dove c’è Angelo Gilardino c’è arte – e lo abbiamo visto – e non può non esserci musica. Infatti oltre alle opere analizzate nella mostra in Arca sono presenti chitarre del XVIII e XIX secolo delle collezioni del liutaio Lorenzo Frignani. Pezzi unici, come quelli realizzati da Carlo e Gaetano Guadagnini, da Denis Nicolao, da Gennaro e Giovan Battista Fabricatore, da Gaetano De Grado, da Pasquale Vinaccia, da Filippo Guarmandi, da Giacomo Zucconi, da Giacomo Rivolta e da Giuseppe Marconcini.
Opere d’arte anch’esse, prodotto dell’eccellenza italiana. Perché, come disse una volta Fabrizio De André, non esistono arti maggiori e arti minori, semmai artisti maggiori e artisti minori. Chi ha costruito e decorato queste chitarre può senza dubbio alcuno arrogarsi il titolo di artista maggiore. Così come lo è stato Angelo Gilardino, l’uomo che è riuscito a far cantare il legno.
Massimiliano Muraro