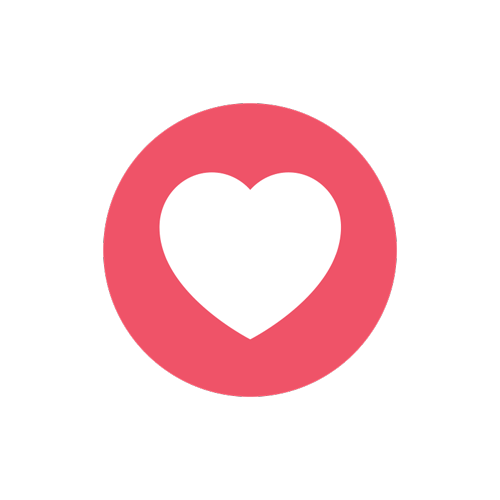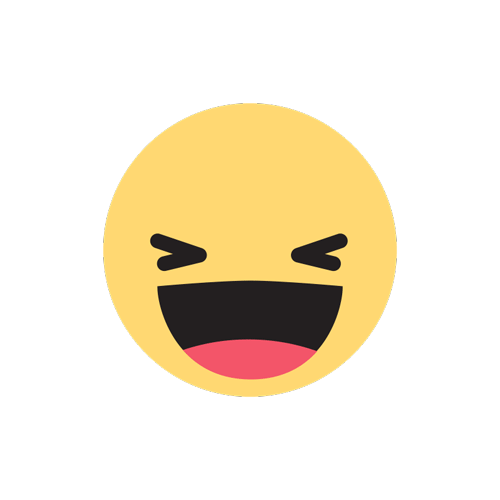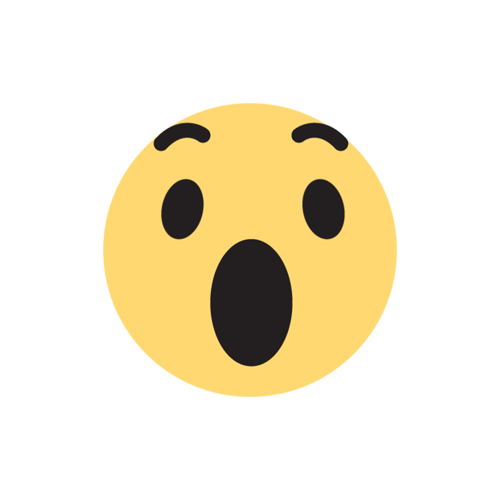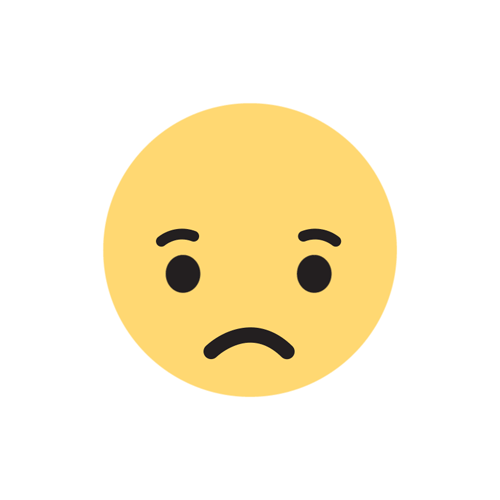Sabato 21 marzo è il giorno che dà l’avvio alla primavera che mai come quest’anno «tarda ad arrivare» e non per una questione meteorologica. È anche il giorno che si è portato via un gigante del giornalismo, l’ultimo della generazione che ha visto esibirsi Beppe Viola, Gianni Clerici e in precedenza Gianni Brera fu Carlo. La generazione di quella Milano odiata e amata da Testori e spogliata da Bianciardi.
Non so perché ma se penso a Gianni Mura che batte sui tasti della sua macchina da scrivere mi viene in mente proprio quella Milano lì: frenetica, industriosa, annerita dai gas di scarico degli autoarticolati, di grasso di motori, di cespugli cresciuti in periferie abbandonate, nutrita dalle trattorie impregnate dal fumo delle sigarette, dalle imprecazioni dei vecchi giocatori di carte e addolcite dai profumi di zafferano, di verze e di ossibuchi.
Mura è stato molto di più di un giornalista sportivo. Come ha detto il mio amico Gabriele, raccontandoci di Baggio e Pantani ci ha raccontato molto, molto di più. E ci ha insegnato, aggiungo io, che una storia, anche la più piccola e insignificante, può spiegare in modo pressoché perfetto l’altra storia, quella con la S maiuscola.
Sì perché Mura mica scriveva solo quello che succedeva nelle partite di serie A, ai Mondiali di Calcio, al Giro d’Italia o al Tour de France. No, Gianni Mura partiva da tutti questi eventi e dipingeva un quadro che ti faceva capire la realtà meglio di qualsiasi libro. Detestava la retorica spiccia, specie quella che pretendeva di rendere epica ogni impresa sportiva, fosse anche la più grandiosa.
Scindeva lo sportivo dall’uomo e quando lo riteneva opportuno dava ora spazio all’uno, ora all’altro. Le sue interviste non si facevano per telefono o con il microfono piantato quasi in bocca. Correggo, e sue non erano interviste, erano chiacchierate tra amici, meglio ancora se accompagnate da un buon bicchiere di vino e da un panino al salame, seduti al tavolo di un’osteria dove fuori si sentivano le voci delle donne al mercato e dei bambini che correvano dietro a un pallone.
Avendo affermato che sospettava di essere di sinistra in attesa di conferme, non poteva premettersi distinzioni di classe. Così eccolo parlare col “facchino” Gimondi, con Sgarbozza il ciociaro, con Benfatto ciclista coi baffi: dal campione al gregario insomma. Ciclismo e calcio sono stati i suoi due esercizi di stile preferiti e li ha narrati, profumandoli di genuina letteratura.
Qualche anno fa lo avevano convinto a pubblicare un libro con tutti i suoi articoli migliori: “Non gioco più, me ne vado”, sottotitolo “Gregari e campioni, coppe e bidoni”. Un manuale di scrittura in tutti i sensi. Una scatola della memoria che contiene pezzi indimenticabili dello sport: l’Inter di Helenio Herrera, il genio di Maradona, l’aplomb di Platini, l’Italia Mundial di Bearzot, il calcio totale dell’Olanda, la rivoluzione sacchiana e le cannonate di Gigi Riva, le imprese sui pedali di Pantani, di Gimondi, di Coppi, di Bartali e quelle di un giorno di Dancelli, di Marino Basso, di Zandegù.
Era il 1986 quando Gianni Mura venne a Vercelli all’allora “Robbiano” per vedere un Pro Vercelli-Mantova di serie C2. Era la Pro del presidente Celoria «la C per noi è come uno scudetto, la C1 il massimo dei sogni», della bandiera esposta al Bar Beccuti in caso di vittoria, dell’esordio in panchina di Oscar Alberto Massei, subentrato a Natalino Fossati dopo sei giornate senza risultati. Ed era la città che restava sì fedele alle bianche casacche, ma che stava scoprendo un altro sport che la stava portando ai massimi vertici internazionali: l’hockey su pista dell’Amatori Maglificio Anna di Pino Marzella.
Mura si siede in tribuna e comincia a parlare con la gente, che qui «fa il tifo come una volta, solo battendo le mani e fischiando». Da buon segugio chiede subito di Piola, ma uno gli risponde che non c’era ed era meglio così perché quando veniva la Pro regolarmente perdeva. Guarda la partita e poi curioso va a visitare la sede dove un signore con gli occhiali gli dice che «siamo come il Regio di Parma per la lirica, ma i grandi artisti si esibiscono altrove».
Racconta, Mura, dei sette scudetti, del titolo regalato all’Inter nel 1910, dei nove giocatori su undici convocati dall’Italia nella sfida contro il Belgio, di Ara e del calcio che non è sport da signorine, del patron Marcello Bertinetti e di Sergio Robutti che gli spiega che all’inizio la Pro è nata come Polisportiva e che la cultura contadina porta all’associazionismo.
Mura è cocciuto: per lui andare via da Vercelli senza aver prima parlato con Silvio Piola è come entrare in un ristorante di Milano e uscirne senza aver mangiato l’ossobuco o la cassoeula. Lo va a trovare e Piola gli dice che quel giorno non c’era perché aveva un battesimo, ma che comunque sia, distando Torino appena un’ora di treno, preferisce godersi Platini, meglio di Sivori, uno che non ha neanche bisogno dell’allenatore tanto è forte. Profetico Piola quando confessa a Gianni che «io ho paura che un giorno o l’altro si sfasci tutto. Basta che perda la Nazionale e si fanno interpellanze alla Camera, siamo il Paese delle esagerazioni».
Gianni Mura conclude il suo reportage elencando gli sportivi vercellesi: Frova, Cantone, Pezzana e Livio Berruti, che si allenava due volte la settimana al campo Coni. E astutamente a chiudere non mette una riflessione sua, ma di Robutti, perché sapeva, Mura, che per descrivere bene un posto sono necessarie le parole di chi ci vive e di chi quel posto ce l’ha nel sangue: «per Vercelli lo sport ha fatto più pubblicità che il riso, e questo i vercellesi non se lo scordano».
Nemmeno i vercellesi e non solo loro, caro Gianni, si dimenticheranno di te. Con quello sguardo eternamente imbronciato, ma con quegli occhi capaci di abbracciare tutto con una bonarietà che però non doveva trasparire troppo. Noi continuiamo a giocare, ma seguiamo il tuo esempio: quando non ci andrà più ce ne andremo.
Massimiliano Muraro