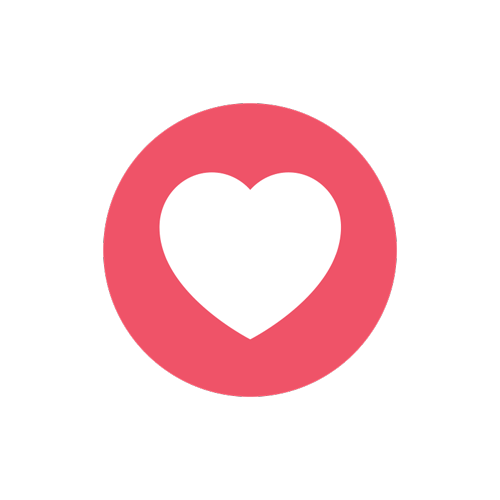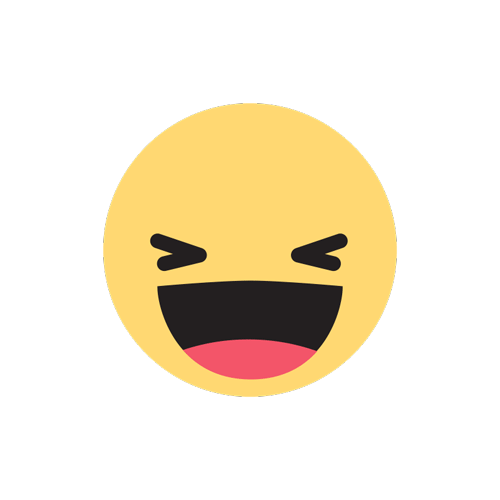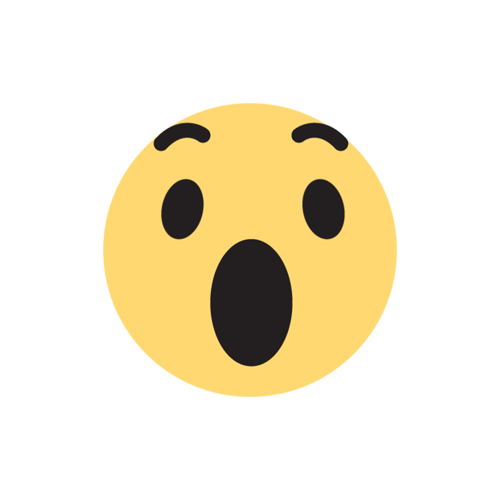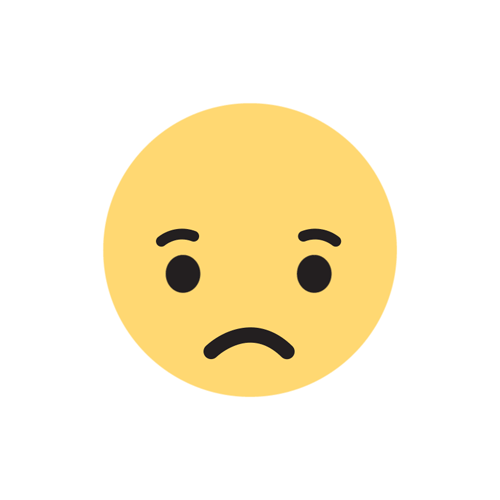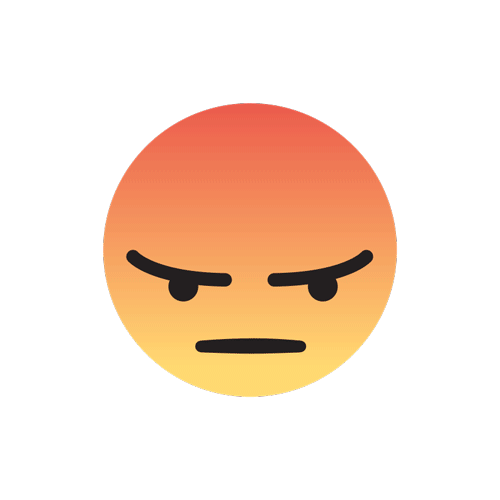Sarà un Venerdì Santo anomalo quello che si accingono a vivere quest’anno i vercellesi. A causa delle restrizioni imposte per limitare la diffusione del virus Covid-19 infatti non andrà in scena la Processione delle Macchine, un rito di teatralità sacra unico nel suo genere, che contraddistingue il Triduo pasquale cittadino insieme alla visitazione delle chiese il Giovedì santo e lo scoprimento del Cristo in Duomo la mattina della domenica di Pasqua.
L’Arcidiocesi, per restare vicina ai suoi fedeli e permettere loro di condividere il momento di preghiera, trasmetterà sul canale Video Nord LCN 72 del digitale terrestre e sul canale satellitare People TV LCN Sky 825 e TivùSat LCN 420 gli appuntamenti della Settimana Santa. Venerdì 10 dalle 20.30 alle 21.15 la preghiera dall’Abbazia di Sant’Andrea; domenica 12 dalle 6 alle 6.50 la Santa Messa dal Duomo; domenica 12 dalle 10.30 alle 11.20 la Santa Messa sempre dal Duomo.
Molti si saranno chiesti dove affonda le sue radici la tradizione della Processione delle Macchine. Ebbene, per scoprirlo tocca fare un salto indietro nel tempo. Cominciamo col dire che le macchine in questione sono grosse sculture in legno policromo che rappresentano gli episodi della via crucis e che vengono portate in spalla dai fedeli lungo il percorso che di solito parte dalla Basilica di Sant’Andrea dove poi il corteo fa ritorno. Sono nove in tutto, la maggior parte delle quali custodite all’interno delle chiese delle confraternite.
Il rito fu istituito ufficialmente nel 1759 dopo una riunione nella chiesa di Santa Caterina e in origine veniva compiuto il Giovedì Santo e non il Venerdì, secondo l’Ordinatio delle Venerande Confraternite di Vercelli. Tuttavia da un inventario della Confraternita di San Bernardino sappiamo che già nel 1622 una «croce granda di legno che si porta zobia santo» sfilava in processione per le vie della città, ma bisognerà aspettare appunto il 1759 per vederla più o meno come lo è oggi.
Per oltre sessant’anni le Macchine non furono nove, ma cinque: il Cristo nell’orto della Confraternita di Santa Caterina, il Cristo alla colonna di San Nicola da Tolentino, la Coronazione di spine di San Bernardino, l’Ecce Homo di Sant’Anna, il Cristo che porta la croce di Sant’Antonio Abate.
Dal 1825 si aggiunsero il Cristo tra i carnefici di Santo Spirito, il Cristo morto di San Giuseppe; più avanti la Mater dolorosa della Compagnia di San Vittore. Fu in quegli anni che l’arcivescovo Alessandro D’Angennes volle che questi otto gruppi si unissero alla processione del Venerdì Santo, organizzata dal Santissimo Crocifisso di Sant’Andrea.
Un capitolo a parte merita la funzione dell’Entierro, documentata a Vercelli in un manoscritto del 1714: Modo di far la Fontione dell’Entierro da Reverendi Padri di San Marco di Vercelli nel Venerdì santo, cominciata nell’anno 1714, con la sua Formola, e Cantate per i Musici. L’Entierro, nato in Spagna come rito funebre, è – come spiega Davide Porporato – «un modello di teatralità sacra che narra della sepoltura del Cristo attraverso un’articolata e complessa cerimonia funebre».
Aggiunge poi che «questo particolare teatro sacro della Settimana Santa a Vercelli è, per alcuni versi, coevo al periodo in cui la chiesa cittadina mette ordine nella confusione rappresentata dalle singole confraternite».
L’Entierro fu vietato nel 1976 per evitare disordini e intemperanze nelle ore notturne, salvo poi essere ripreso con modalità differenti in anni più vicini a noi. Ricordiamolo nel 1986, nel 1987, nel 1998 in una versione più prossima alla liturgia e nel 2006 quando si avvalse di supporti multimediali. Lo scorso anno la Camerata Strumentale “Bernardino Lanino” della scuola media “Sandro Pertini” di Vercelli lo ha omaggiato in un concerto tenuto all’interno della chiesa di San Cristoforo.
Tornando alla Processione delle Macchine vogliamo concludere usando le parole con cui l’ha descritta Porporato, cioè «uno degli elementi identitari che concorrono a definire i tratti costitutivi della città. La popolazione partecipa con affetto e trasporto trovando nel lutto teatrale del Venerdì Santo le ragioni logiche e affettive che altre feste, altri tempi cerimoniali e rituali non dispensano più. Essa sacralizza il territorio cittadino che la quotidianità, l’usura del tempo cronometrico contemporaneo depotenziano nell’arco dell’anno».
Massimiliano Muraro