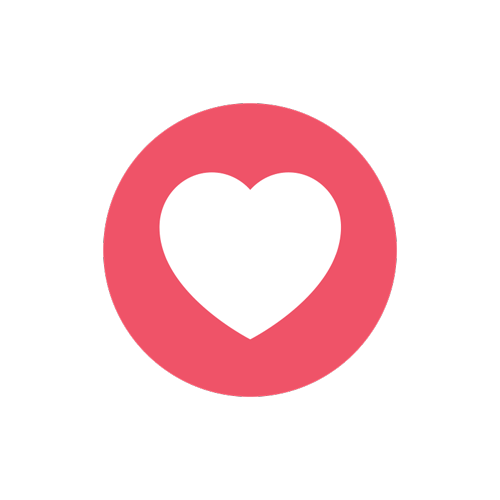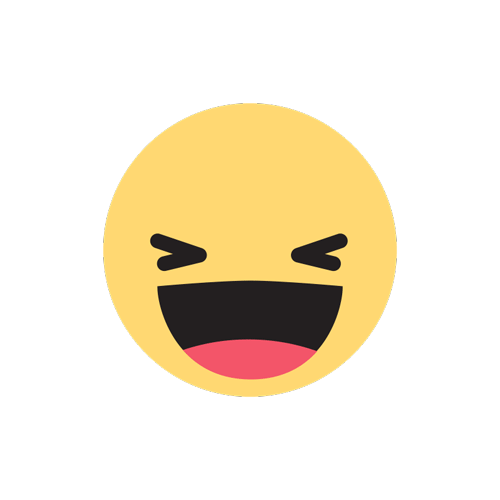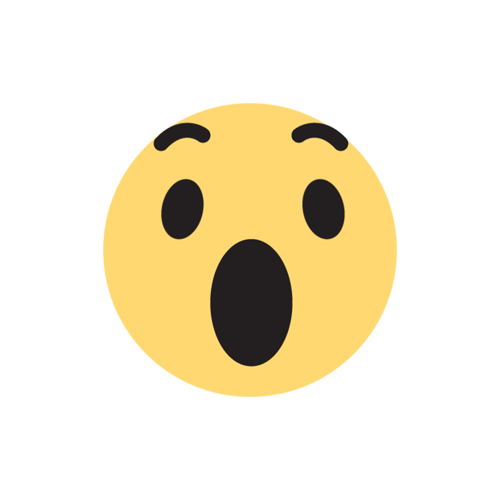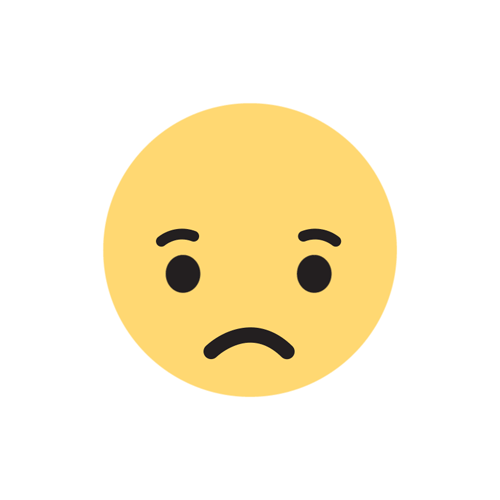Giorno 3: Stelvio, sentiero Valtellina
Per me e Giacomo è il terzo giorno, quello che chiuderà il nostro Tabac Brevet. Dopo l’impegnativa prima tappa con Aprica, Gavia, Foscagno, Eira e quella di mercoledì con Fuorn, Umbrail, Stelvio e Resia, giovedì chiudiamo il cerchio ancora con lo Stelvio, ma questa volta preso da Prato, poi ci tuffiamo a Bormio per ritornare alla base di Teglio, costeggiando la statale 38 lungo il sentiero Valtellina.

Questa volta restiamo nel letto un’ora in più, abbiamo fatto i nostri conti e abbiamo convenuto che ce lo possiamo permettere. Dopo una lauta colazione inforchiamo le nostre bici e da Resia ci buttiamo verso Prato allo Stelvio, questa volta dalla statale. Non vogliamo brutte sorprese come ieri. È tutta discesa, quindi quasi non si pedala, anche se così a freddo è buona cosa far girare le gambe onde non raffreddarsi troppo. Passando per una via che costeggia i meleti ci facciamo anche una doccia non richiesta a causa degli innaffiatori che sono posizionati più in alto degli alberi e che non fanno distinzione tra foglie, frutti e passanti.
La salita allo Stelvio da Prato misura circa 25 km con un dislivello di 1.808 metri, pendenza media 7.4%, massima 9.2% (anche se il Garmin segnerà in alcuni punti il 12%). Lo Stelvio è l’università del ciclismo, nel senso che ogni amatore dovrebbe farlo almeno una volta nella vita. Quando lo hai scalato ti senti un po’ più completo di prima e poi non vedi l’ora di rifarlo. La strada statale 38 che si arrampica da questo versante conta la bellezza di 48 tornanti. Il valico stradale più alto d’Italia (in Europa secondo solo all’Iseran, mentre la Bonette non la contiamo in quanto peccato di presunzione dei francesi) è il capolavoro del bresciano Carlo Donegani.

Quando nel XIX secolo l’impero austriaco prese possesso della Lombardia una delle prime preoccupazioni fu di collegarla al Tirolo coinvolgendo la Valtellina e la Val Venosta. A progettare i quasi 50 km di quella strada che sarebbe presto diventata leggenda fu chiamato Carlo Donegani che aveva già ideato il Naviglio di Brescia e che si era messo in evidenza costruendo la Lecco-Colico, poi proseguita sino a Chiavenna. I lavori sullo Stelvio iniziarono nel 1822 e durarono tre anni. Per questa impresa monumentale, tra tecnici e operai furono impiegati oltre 2.500 uomini. L’inaugurazione ufficiale avvenne nel 1825 alla presenza dell’imperatore Ferdinando il quale, una volta nominato Re di Lombardia, conferì a Donegani il titolo di Cavaliere dell’Impero Austriaco e di Nobile di Stilfserberg, cioè del Monte Stelvio. Donegani morì prematuramente, in molti dicono per gli sforzi compiuti sullo Stelvio.
Questo lungo serpente d’asfalto, che divenne tale nel 1928, è entrato nell’immaginario collettivo grazie al Giro d’Italia che vi è transitato un’infinità di volte. La prima nel 1953. A conquistarlo non poteva che essere Fausto Coppi, celebrato su al passo da una stele che lo ricorda, a essere sinceri piuttosto bruttina e quasi invisibile, nascosta dai negozi di paccottiglia a uso e consumo dei turisti. Da quel momento lo Stelvio, quando la corsa rosa ci è passata, è sempre stato la Cima Coppi (nome dato alla vetta più alta sfidata dai corridori) per antonomasia. Ed è sempre lì che nel 1980 si consumò la tragedia sportiva di Wladimiro Panizza che aveva provato a sfidare gli dei venendo punito dal più combattivo e implacabile di essi: Bernard Hinault che insieme al suo fedele luogotenente Bernaudeau sfiancò il povero Panizza, novello e sfortunato Prometeo, facendogli capire che la maglia rosa non era roba per lui.

La nostra avventura sullo Stelvio non inizia nel migliore dei modi: appena fuori da Prato si trova il giardino delle sculture di un artista-sciamano del posto, che nelle sue opere vuole recuperare lo spirito degli indiani d’America. L’avevamo già notato il giorno precedente quando stavamo scendendo. Infatti è pieno di totem, di simboli dei nativi, ma anche di tante installazioni bric-à-brac realizzate con robe vecchie e cianfrusaglie. Impossibile non fermarsi a fare una foto. Ma ecco che spunta il padrone di casa, piedi nudi e cappello ornato di piume, che ci chiede di cancellare lo scatto: la sua arte si paga, non è gratis. È piuttosto aggressivo, ma io gli dico che in fondo mi interessa sapere cosa fa.
È come parlare al muro: lui parte con una lunga tiritera sul fatto che gli importa solo che i visitatori comprino le sue opere, che dell’arte non gliene frega nulla se non per mangiare e altre amenità del genere. Giacomo si allontana, io provo a spiegargli che sono su una strada pubblica e che fotografo ciò che voglio e che è inutile parlare con uno che risponde solo «non me ne frega nulla». Poi mi congeda dicendo che mi vuole bene perché ho cancellato la foto e mi augura buona scalata. Io al contrario gli auguro di andare altrove, ma sempre col sorriso sulle labbra.
Riprendiamo increduli la via che sale prima dolcemente, per poi iniziare a fare sul serio da Trafoi, dove è nato l’asso dello sci, simbolo della Valanga Azzurra, Gustav Thöni che lì ci ha aperto un bell’hotel. Il mio chiodo fisso però sono i 48 tornanti che mi si presenteranno inesorabili davanti agli occhi. Ho già deciso che non guarderò il Garmin per sapere quanto manca al passo, né il dislivello. Farò il conto alla rovescia: da 48 bisogna arrivare a 1, di strada ce n’è ancora un bel po’ da fare.

La fatica dei giorni precedenti, unita al peso della bici, zavorrata con la sacca dietro la sella, si fa sentire. Poi, non dimentichiamo che c’è da salire quasi a 2.800 metri. Il tratto per me più granoso è nel bosco: è irregolare e raggiunge spesso pendenze sopra il 9%. Con Giacomo ci siamo detti che ci aspetteremo all’ hotel a metà strada per caricare le borracce e così infatti facciamo.
Da lì non ci sono più alberi, si esce allo scoperto. Sulla sinistra l’imponente ghiacciaio dell’Ortles, sulla destra il capolavoro di Donegani che conduce ai 2.758 metri. Giacomo mi dice che da lì inizia la parte dura. Sono arrivato ben oltre metà strada stanco e provato, un po’ sono allarmato dalle parole del mio amico. Inoltre alzando la testa si vede troneggiare il Rifugio Tibet, incastonato a 2.800 su un vertiginoso sperone di roccia. Sapere che bisogna arrivare fin lassù è un duro colpo per la mia tenuta mentale. Mi dico che è meglio non prenderlo come punto di riferimento. Così ripenso al motto di Felice Gimondi: «Testa bassa e menare!». Menare qui sarebbe inutile, ma la testa bassa, o quantomeno a mezza altezza, può tornare utile.
Poco per volta il numero sui tornanti si abbassa e poi si sale regolare, non a strappi, per cui mi trovo perfettamente a mio agio nel cadenzare la pedalata. Purtroppo quando mancano 3 km assisto a una brutta scena: un incidente tra una moto e una bici. Temo il peggio, ma per fortuna il ciclista se l’è cavata solo con qualche escoriazione. Supero senza problemi altri colleghi che stanno arrancando al contrario di me. Mi sento più leggero, la stanchezza sembra non esistere più. Forse saranno la voglia e l’entusiasmo di domare lo Stelvio.

La conquista della vetta è una liberazione che sia io che Giacomo non possiamo goderci troppo. Si è rannuvolato e comincia a scendere qualche goccia. A 2.800 metri potrebbe significare anche neve, così come avevamo fatto ieri partendo da Livigno, indossiamo manicotti, scaldacollo, guanti lunghi, mantellina e ci lanciamo in picchiata verso Bormio. Io non vedo l’ora di scendere sotto i 2.000 metri perché fa davvero freddo, al punto che non riesco neppure a godermi il paesaggio di cui Giacomo mi aveva decantato le virtù.
Come per magia, scesi sotto le nuvole, l’aria si scalda e noi possiamo fermarci a fare qualche foto e a godere del panorama. Il versante da Bormio è più selvatico, meno da copertina di quello di Prato, ma sicuramente altrettanto spettacolare. Mi riprometto che tornerò a farlo il più presto possibile. Unico neo: ci sono diverse gallerie, alcune delle quali buie. Nel Giro del 1994 Brian Smith disse che «non sono tipo da spaventarmi in discesa, ma non dimenticherò mai quel giorno allo Stelvio, le mani gelate, un occhio chiuso all’ingresso delle gallerie e le dita incrociate una volta dentro. Ero pietrificato. È stata la discesa più terribile che io abbia mai fatto». Chiaramente noi non eravamo in gara, ma posso garantire che quei tunnel non sono quella che di solito si usa definire una passeggiata.

A Bormio la sosta per il panino in un bar è funestata dai nostri vicini di tavolo che sbraitano sui temi del momento, sciorinando una serie di luoghi comuni che renderebbero indigesta anche una semplice caramella. Ci sbrighiamo perché dobbiamo anche capire dove inizia il sentiero Valtellina, una lunga ciclabile di oltre 100 km che arriva fino a Colico e che permette di evitare la pericolosa statale brulicante di camion, auto e moto. Chiediamo informazioni e la troviamo quasi subito. Da lì a Teglio sono poco meno di 60 km per lo più pianeggianti e quel che conta senza alcuna impennata.
Il sentiero è molto tranquillo, poco frequentato e soprattutto ben segnalato. Solo un tratto di pochi km ci costringe a tornare sulla strada principale. Si passa attraverso paesi i cui nomi suonano nuovi a entrambi, non c’è nessuno in giro, ma è l’ora di pranzo ed è comprensibile. Costeggiamo l’Adda le cui acque non sono come le aveva descritte Manzoni, ma alquanto limacciose e inquietanti. Un velo di tristezza scende quando ci troviamo sulla destra gli effetti della tragica alluvione che colpì la Valtellina nel 1987, una ferita tuttora aperta sul crinale della montagna e nel cuore di chi lì ci abita.

Prima di arrivare a Sondrio, a Mazzo c’è l’indicazione per il Mortirolo, la salita che nei nostri piani d’origine doveva essere affrontata per prima, sostituita dall’Aprica. Non ce la sentiamo, lo teniamo per la prossima volta. È anche un incentivo per tornare a pedalare da queste parti. A Sondrio rischiamo di perderci perché non troviamo più segnalazioni per il sentiero Valtellina. Ci aiuta una giovane donna che porta a spasso in bici suo figlio.
Sul ponte dell’Adda non sappiamo se andare a destra o sinistra, provo a inserire i dati sul navigatore, ma sono troppo stanco per starci dietro. Mancano comunque 5 km al traguardo. Sopraggiunge un collega ciclista che si offre di accompagnarci un pezzo. Gli chiediamo che giro aveva fatto, ci risponde che dopo mangiato non sapeva dove andare e ha deciso di farsi il Mortirolo da Mazzo. Lo guardiamo sbigottiti, lui è il primo a riderci su. Ci dice anche che ci accompagnerà solo un pezzo perché poi per arrivare dove siamo diretti noi c’è un muro che non ha voglia di fare. Figurarsi noi!

Ora riconosco la strada, è quella che ho fatto tre giorni prima in auto. E so già che per arrivare al Vecchio Torchio ci toccherà una parete di asfalto al 20%. Abbiamo 390 km e 9.000 metri di dislivello nelle gambe, una zavorra dietro la bici, la testa svuotata, ma bisogna farla. Tutti e due diciamo che al limite scendiamo a piedi, ma costi quel che costi il nostro obiettivo e di restare in sella. Il Muro della Gatta (così è chiamato questo strappo) è terrificante, meglio tenere la testa bassa, anche perché a spostarsi troppo col corpo indietro si rischia di alzare la ruota anteriore.

Il tratto al 20% è superato, intravediamo le nostre auto parcheggiate e lo spiazzo dove finalmente potremo staccare le scarpette dai pedali. È fatta, ci buttiamo a terra e svuotiamo quel che resta nelle nostre borracce. La prima edizione del Tabac Brevet è stata portata a termine. Ci sentiamo un po’ dei pionieri e come ultima cosa, da prassi, ci scattiamo una foto per documentare il tutto.
Posiamo le bici, andiamo a farci la doccia, scendiamo, svuotiamo un paio di meritate birre e ci sediamo a tavola dove sappiamo ci aspetta il premio più ambito: un piatto fumante di pizzoccheri che proprio qui a Teglio sono nati. Finiscono così tre giorni di viaggio e di continue scoperte, perché la bicicletta porta davvero ovunque, non soltanto il corpo, ma anche la mente. È questo il sunto del ciclismo di contrabbando, almeno come lo intendiamo noi: 390 km, 9.000 metri di dislivello e tanto divertimento.
Massimiliano Muraro