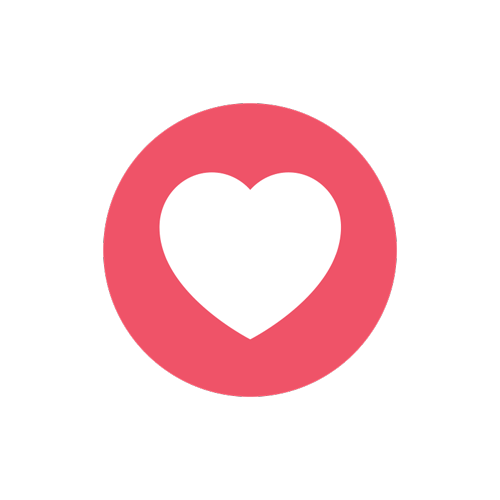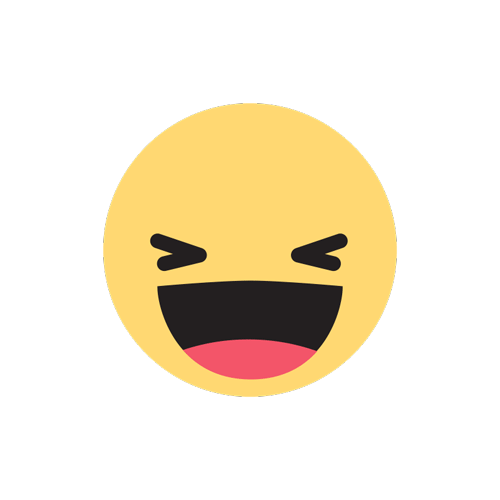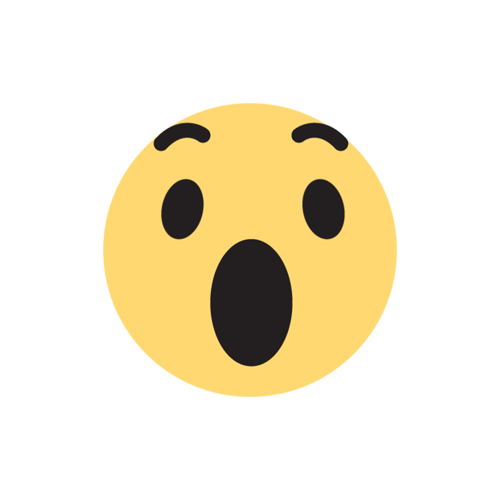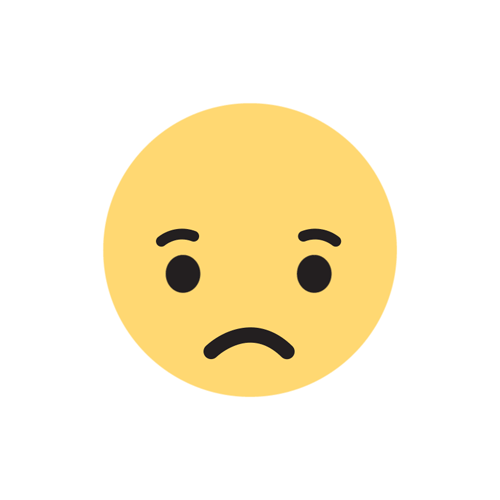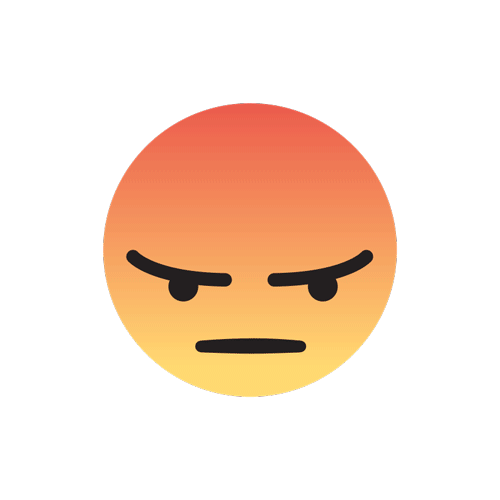Premesso che tutte – e sottolineiamo tutte – le opere esposte nella grande mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” (in Arca fino al 1° luglio e nelle sedi di Varallo e di Novara) sono di eguale importanza e di interesse storico-artistico, al punto che sarebbe fuorviante stilare una classifica, ve ne sono alcune che meritano un’analisi più dettagliata, non fosse altro per il fatto che sono prestiti internazionali, a Vercelli in via del tutto eccezionale.
Così è per il “Compianto su Cristo morto” dello Szépmüvészeti Múzeum di Budapest e soprattutto per “Adorazione del Bambino con un vescovo” del Ringling Museum of Art di Sarasota che, al di là del suo valore intrinseco, ha alla spalle una storia tanto travagliata quanto suggestiva, a cominciare dai numerosi passaggi di proprietà che l’hanno portata fino in Florida.
Come si legge nella scheda sul sito del Museo (https://fla.st/2GFG5DT), l’opera fu lasciata in eredità alla contessa Livia Arcimblodi dal marito conte Antonio a Milano nel 1682; fu poi venduta per 5.000 fiorini a Jean-Baptiste Etienne di Bruxelles e in seguito a Henry Farrer di Londra per 40.000 franchi; passò poi alla collezione Holford di Dorchester nel 1854; battuta all’asta da Christie’s il 15 luglio del 1927, nello stesso anno fu comprata da John Ringling, uno dei fratelli che nel 1907 acquisì il Barnum & Bailey Circus, e infine ceduta come lascito al John and Mable Ringling Museum of Art nel 1936.
Dal catalogo della mostra su Gaudenzio al Museo Borgogna nel 1956, compilato da Giovanni Testori, sappiamo che l’Adorazione fu esposta a Londra nella “Milanese Art Exhibition” del 1899 e a San Francisco nella “Golden Gate International Exposition” del 1940. Inoltre Testori ci dice che una replica antica si conserva nel Museo dei Benedettini a Fécamp in Francia.
L’attuale datazione della tavola è del 1530 circa, quindi la sua esecuzione è stata spostata leggermente avanti rispetto a quella proposta da Testori che sosteneva fosse collocabile all’inizio del secondo decennio. Si è comunque concordi nell’affermare che non si tratta di un lavoro della maturità, come riteneva la letteratura precedente. «Ha dei capolavori di questo tempo, tutto il fascino e la dolce poesia», scrive Testori. Elementi che non lasciarono indifferenti gli artisti coevi, come ad esempio Gerolamo Giovenone.
Il soggetto ritratto è facilmente riconoscibile: la Sacra Famiglia con un vescovo offerente del quale non si conosce l’identità precisa, ma secondo studi recenti potrebbe essere Giovanni Angelo Arcimboldi. La tradizione, riportata anche da Testori, pensava invece si trattasse del cardinal Taverna. Gesù Bambino poggia sul manto della Madonna e il suo capo è sorretto dalla mano di uno dei due pargoli che si trovano tra la Vergine e San Giuseppe. In primo piano un angioletto volge lo sguardo al volto amorevolmente materno di Maria. In alto due putti reggono un cartiglio. La scena si svolge in un tipico ambiente leonardesco con la grotta e il paesaggio sfumato sullo sfondo che occupa i due terzi dello spazio.
Proprio la sua apertura verso i modelli lombardi fa di quest’opera un caposaldo della poetica gaudenziana. Sappiamo infatti che in quegli anni l’artista stava avviando i rapporti con Francesco II, ultimo duca Sforza, che nel 1530 si era recato in pellegrinaggio al Sacro Monte di Varallo. Fu il nobile a chiamare Gaudenzio a Milano, in virtù della contemporanea scomparsa di Bramantino e di Bernardino Luini, due nomi autorevoli nel panorama artistico meneghino e non solo. Per sostituire Luini, tra il 1534 e il 1536, Gaudenzio fu incaricato di completare gli affreschi della cupola della chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Saronno. Una committenza di alta responsabilità che lo consacrò definitivamente come artista di spicco della cultura milanese.
Nel periodo di esecuzione dell’Adorazione Gaudenzio mette a frutto le contaminazioni linguistiche che aveva appreso dopo le vicende di San Cristoforo, aprendosi al dialogo con la vicina Lombardia che da qualche tempo era stata rinfrescata dalla lezione di Leonardo. La cura nel disegno, l’eleganza dei tratti, l’attenzione ai colori, la composizione della scena, i gesti dei personaggi che la occupano testimoniano il percorso intrapreso dall’artista, senza dubbio uno dei più influenti del Rinascimento settentrionale.
Massimiliano Muraro